Con il comunicato n. 59 del 16 novembre, il governo Meloni dà conto d’aver varato, tra gli altri, un disegno di legge il cui contenuto conferma, con disarmante puntualità, che trattare di cose di giustizia non è agevole, specie senza i preventivi opportuni approfondimenti.
Il DDL, che – facile presagio – troverà canali preferenziali di trattazione in un parlamento che si barcamena tra la narcosi dei mantra iracondi del buttare la chiave e marcire in galera e l’impalpabile sciccheria di dialoghi da Bar Casablanca così cari all’opposizione, introduce alcune novità di tutto rilievo, in grado di incrinare ancora un po’ le malferme fondamenta dello Stato di diritto nel nostro paese, passando per le vie centrali del diritto e della procedura penale.
Soffermarsi su tutto non è semplice e forse nemmeno utile, mentre spiccano, sul resto, due interventi e un principio di fondo.
Il principio di fondo racconta che c’è ancora qualcuno in giro che ritiene – o almeno così vuol far credere – che pene asperrime possano neutralizzare il delitto e che, in conseguenza, innalzare quelle esistenti serva a qualcosa e moltiplicare le fattispecie di reato pure. Non c’è un’altra chiave, del resto, per leggere la introduzione di nuove fattispecie di reato che codificano la rilevanza penale di condotte sulla cui riprovevolezza non v’è da discutere, nel senso che non la si scorge nemmeno al microscopio.
E così, dal principio passando al primo intervento, diventa reato – e che reato: da uno a sei anni! – la resistenza passiva all’esecuzione degli ordini impartiti dalle autorità in un centro di trattenimento (sintagma mellifluo per carcere) da parte dello straniero, perché, se sei straniero devi fare lo straniero e obbedire, sennò te ne torni a casa tua a protestare, in maniera passiva e non violenta, contro ciò che reputi un sopruso. Del resto, Ghandi non è nato mica in Italia.
Ma anche quando una riprovevolezza della condotta invece si scorge, non è che le cose vadano meglio. Come quando diventa reato anche la “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui” (con tetto massimo addirittura superiore: sette anni); anche perché entrare con violenza o minaccia nella proprietà privata altrui o, peggio ancora nell’altrui domicilio, è già un fatto penalmente rilevante. E, infatti, qui la novità vera è procedurale: se ordinariamente il rapido rientro nel possesso dell’immobile è garantito a chi ne sia stato spogliato da un intervento immediato del giudice, allorquando l’immobile sia la sua unica abitazione, affiora una nuova entità meta-giurisdizionale, la polizia giudiziaria, che, con un atto di imperio e salva la successiva convalida, scrutinati in ipotesi titoli abilitanti contrapposti sulla base di non si sa quale criterio di giudizio, dispenserà una giustizia di velocità, il cui fondamento sfugge alla comprensione, sfrattando illico et immediate il reo e restituendo alla vittima quanto le è stato sottratto. Ce ne vuole per non capire la crepa che una simile previsione apre nel sistema, decentrando l’esercizio della funzione giurisdizionale fuori dai casi extrema ratio già fissati dal codice.
E se poi un reato c’è già si può sempre inasprirne le pene o aggravarne le modalità esecutive.
C’è davvero l’imbarazzo della scelta.
Solo per fare alcuni esempi: dalla truffa aggravata alla resistenza a pubblico ufficiale, dalla deturpazione di mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche alla istigazione a disobbedire alle leggi rivolta a persone detenute; un tripudio di nuove fattispecie, insomma.
Al di là dei puntuali interventi, però, come si diceva, è l’idea che sorregge il DDL a meritare riflessione, essendo in grado di lumeggiare un quadro ideale desolante, che viaggia in direzione opposta a qualsiasi idea liberale del diritto e del processo penale.
Si obbietterà – con una certa ragione – che, al di là dei primi vagiti illusoriamente rassicuranti di questo governo (meglio: del suo Ministero di Giustizia), è ormai chiaro da un po’ di tempo che liberale non è affatto un lemma descrittivo della compagine.
Torniamo allora al principio, stavolta però precisandone la vacuità: moltiplicare il numero dei delitti o inasprire le pene non solo non serve, ma guasta, perché alimenta l’idea che la contromisura dello Stato alla violazione dei precetti vada perdendo ogni equanimità, trasmodando sul piano della pura reazione vindice. Ciò che è confermato da ogni osservazione del fenomeno degli effetti della sanzione e della sua modalità di esecuzione; se così non fosse, regnerebbe la pace sociale in quelli tra gli Stati Uniti d’America in cui la pena di morte è legge. Mettiamola così allora: anche a non esser liberali, basterebbe perseguire per davvero un po’ dell’efficienza di cui ci si adorna in ogni circostanza pubblica per avvedersi della banale verità che non è affatto l’entità della pena o il numero delle fattispecie incriminanti a garantire maggior sicurezza sociale; che è insomma una pia illusione credere davvero che il legno storto dell’umanità si possa raddrizzare a bastonate.
Non saremo la patria di Ghandi, ma restiamo pur sempre quella di Beccaria, anche se qualcuno spesso se ne dimentica.
_______________________________________________________
Avv. Giuseppe Belcastro – penalista del foro di Roma
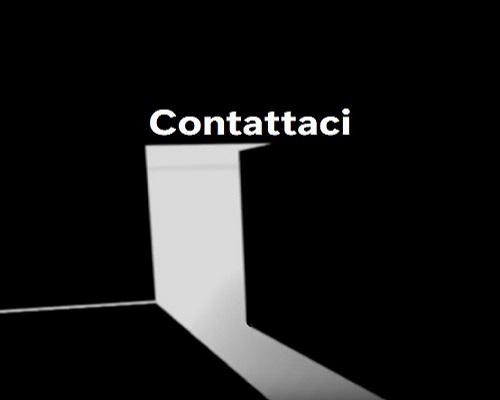
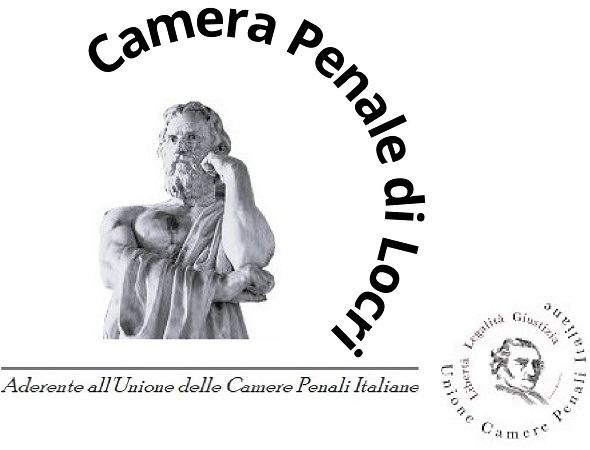
Utilizzando il Form acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni sulla nostra modalità di gestione della privacy, clicca qui
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni, clicca qui
