La norma di cui all’art. 227 c.p.m.p. punisce il delitto di diffamazione militare stabilendo che:
- Il militare, che, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.
- Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
- Se l’offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.
Gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione militare sono individuati nell’offesa all’onore o al decoro altrui, nella comunicazione con più persone e in assenza della persona offesa.
Bene giuridico tutelato dalla norma è, pertanto, l’onore della persona offesa quale valore costituzionalmente tutelato e requisito essenziale per la configurabilità del reato consiste nel fatto che sia il soggetto attivo che quello passivo siano entrambi militari, a nulla rilevando il rapporto gerarchico intercorrente fra gli stessi.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo del delitto in questione, il reato di diffamazione si considera integrato dal dolo generico, vale a dire dalla coscienza e volontà di comunicare a più persone l’offesa dell’altrui reputazione.
Esaminando il testo della norma, i tre commi che la compongono guidano a comprendere la differenza fra il delitto di diffamazione militare semplice e quello di diffamazione militare aggravata.
Nello specifico, qualora l’offesa arrecata consista nell’attribuzione di un fatto determinato o sia recata per mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, oppure l’offesa sia recata a un corpo militare, il delitto si presenterà nella sua forma aggravata.
Il reato di cui all’art. 227 c.p.m.p. comma 1 è procedibile solo su istanza del Comandante di Corpo, il quale deve necessariamente fare richiesta di procedimento ai sensi dell’art. 260 co. 2 c.p.m.p. Qualora, al contrario, il Comandante di Corpo non si avvalesse di tale possibilità, il reato potrebbe essere punito unicamente mediante sanzione disciplinare.
Al contrario, per quanto riguarda le ipotesi previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, punite con pena superiore nel massimo a sei mesi, il Comandante non può avvalersi della facoltà di cui all’art. 260, co. 2 c.p.m.p e si procederà direttamente mediante procedimento penale.
Appare doveroso procedere ad una digressione circa il reato di diffamazione comune previsto e punito dall’art. 595 c.p. secondo cui
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
È possibile notare, già dalla semplice lettura, come la disposizione normativa sia grossomodo speculare alla norma di cui all’art. 227 c.p.m.p. e sicuramente costante sia l’elemento del “mezzo di stampa” e di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” come aggravante della fattispecie di reato.
Tuttavia, il reato di diffamazione spesso viene confuso con quello di ingiuria, ma i reati sono notevolmente diversi.
In via esemplificativa, la diffamazione, come già esposto, consiste nell’offesa pronunciata in assenza della vittima davanti a più persone. L’ingiuria si rivolge, invece, direttamente alla persona offesa.
Giova ricordare, in via preliminare, che la disciplina dell’ingiuria nel codice penale è cambiata nel corso del tempo: in passato la legge la configurava come reato; a partire dal 2016 l’ingiuria è stata depenalizzata.
Tuttavia, resta la configurazione dell’ingiuria militare (art. 196 c.p.m.p.), delitto punito nei termini che seguono:
- Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. 2. Il militare, che offende il prestigio, l’onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni. 3. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all’inferiore. 4. La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell’articolo 339 del codice penale. 5. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.
Oltre la tutela di interessi giuridici diversi (da un lato la reputazione, dall’altro l’onore e il decoro), le sostanziali differenze si fondano sulla presenza della vittima nell’ingiuria e assenza della vittima nella diffamazione (con la contestuale previsione che l’offesa sia fatta alla presenza di più persone).
Proprio questa notevole differenza fra i due reati risponde all’interrogativo del quisque de populo in ordine al fatto che, sebbene oggetto di entrambi i reati sia comunque un’offesa, i delitti siano puniti con pene differenti.
È chiaro: l’assenza della persona offesa nel reato di diffamazione non consente alla stessa di potersi difendere o ribattere alle offese ricevute aggredendo così il bene giuridico tutelato dalla norma in maniera certamente più lesiva rispetto a quanto possa avvenire con il reato di ingiuria.
Quale reato è ascrivibile, allora, in caso di scritti offensivi mediante chat di gruppo su whatsapp?
A rispondere è la Cassazione: nel caso di invio di espressioni offensive a una chat di gruppo si configura l’ingiuria quando vi sia contestualità fra comunicazione dell’offesa e recepimento della stessa da parte dell’offeso; in difetto di contestualità, si configura la diffamazione (Cass. Pen., sentenza n. 27540/2023).
La questione è di particolare attualità in quanto, in ragione dell’uso improprio delle moderne forme di comunicazione, il reato di diffamazione ha visto una crescita proporzionale al potenziamento dei social network e delle applicazioni di messaggistica istantanea.
Sul punto, appare utile spiegare il caso di una recente pronuncia della Suprema Corte in ordine alla questione della configurabilità o meno della diffamazione militare aggravata nell’eventualità in cui la diffusione abbia ad oggetto un messaggio offensivo in una chat dell’applicativo “whatsapp”.
Riguardo ai fatti: la Corte Militare d’Appello dichiarava di non doversi procedere nei confronti di un militare per il reato di diffamazione aggravata per mancanza della richiesta di procedimento.
In sostanza il militare comunicando con alcuni colleghi tramite l’applicativo Whatsapp in una chat di gruppo ristretta, avrebbe inviato più messaggi offensivi nei confronti di altri militari.
Con sentenza n. 37618/2023 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione viene enunciato il seguente principio: «in tema di diffamazione militare, la diffusione del messaggio offensivo in una chat dell’applicazione WhatsApp non configura l’aggravante dell’uso di un “mezzo di pubblicità”, trattandosi di strumento di comunicazione destinato ad un numero ristretto di persone, e privo della necessaria offensività». In altri termini, in tema di diffamazione militare, l’ipotesi dell’offesa recata con l’uso di un “mezzo di pubblicità” va esclusa nel caso specifico in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante l’utilizzo di una chat privata e ristretta, a nulla rilevando la circostanza che il messaggio diffamatorio, destinato ad un numero ristretto di persone possa essere inoltrato ad altri, poiché tale condotta sarebbe opera del destinatario del messaggio in questione e non del mittente.
In questa prospettiva, l’utilizzo di una chat di gruppo alla quale appartiene un numero esiguo e limitato di persone non integra l’ipotesi delittuosa della diffamazione aggravata commessa con un “mezzo di pubblicità”, bensì integra l’ipotesi delittuosa della diffamazione semplice.
Come noto, la ratio della previsione normativa contenuta nell’art. 227, comma 2 c.p.m.p. risiede nel particolare vulnus che può essere arrecato alla persona offesa, nel caso in cui la condotta incriminata nell’art. 227, comma 1 c.p.m.p. sia stata commessa dal soggetto attivo del reato con modalità idonee ad una propagazione incontrollata del contenuto diffamatorio.
La caratteristica essenziale della diffamazione di cui all’art. 595 c.p. e della diffamazione militare di cui all’art. 227 c.p.m.p. consiste nell’offesa alla reputazione altrui, in un contesto comunicativo. L’aumento di pena di cui all’art. 595, comma 3 c.p. nonché all’art. 227, comma 2 c.p.m.p. si applica a fronte della particolare diffusività del mezzo (di pubblicità) utilizzato e quindi del numero cospicuo ed interminato di persone che l’offesa tende a raggiungere.
Con particolare riguardo al sistema di messaggistica istantanea WhatsApp, la recente giurisprudenza di legittimità ritiene si tratti di uno strumento di comunicazione, relativamente al quale il messaggio inviato in una chat di gruppo raggiunge solo ed esclusivamente i soggetti iscritti alla suddetta chat di gruppo, precisando che si tratta di soggetti che reciprocamente si sono accettati.
In questa prospettiva, l’aggravante dell’uso di un “mezzo di pubblicità” si configura nel solo caso in
cui il mezzo utilizzato sia idoneo ad ampliare la capacità diffusiva del messaggio diffamatorio per il fatto di coinvolgere un numero indeterminato di persone ed infatti la funzione di uno strumento di comunicazione e condivisione telematica (quale può essere il social network Facebook) è proprio quella di incentivare la frequentazione di un numero sempre più esteso di persone aggravando la diffusività del messaggio diffamatorio, lesivo della reputazione altrui (cfr. Sez. V, n. 4873 del 2016; Sez. I, n. 2443 del 2015).
In merito alla capacità diffusiva del mezzo utilizzato, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si ravvisano sentenze nelle quali viene ribadito che la condotta di invio di una e-mail o lettera ad un numero determinato di destinatari non è idonea ad integrare l’aggravante di cui all’art. 595, comma 3 c.p., ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, nonché il divieto di analogia in malam partem; al contrario la diffusione di un messaggio diffamatorio mediante l’uso della bacheca Facebook integra l’ipotesi della diffamazione aggravata, trattandosi di uno strumento, per comune esperienza, destinato ad essere consultato da un numero indeterminato di persone.
Nella sentenza indicata la suprema Corte di Cassazione, condividendo le argomentazioni spese dalla
Corte Militare d’Appello, giunge alla conclusione che gli strumenti digitali non funzionano tutti allo stesso modo: In sintesi, l’utilizzo di una chat di gruppo ristretta, quindi riservata, non integra l’aggravante dell’uso di un “mezzo di pubblicità” poiché non è idonea a raggiungere un numero indeterminato di persone, come invece accade per i siti internet e per i social media. Lo scambio di messaggi è riservato e non idoneo a produrre una diffusione incontrollata.
In conclusione, non può ritenersi che una chat di messaggistica riservata sia idonea a realizzare una comunicazione aperta ad un numero indeterminato di persone, poiché trattasi di comunicazione che conserva la connotazione essenziale della riservatezza, quindi risulta destinata ad un numero definito e previamente concordato di persone con la conseguenza che non si può ritenere che una chat di messaggistica chiusa possa rientrare nella nozione di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” di cui all’art. 595, comma 3 c.p. e 227, comma 2 c.p.m.p.
Proprio in ordine al reato di diffamazione a mezzo whatsapp, si è appena concluso un processo dinanzi al Tribunale Militare di Roma che vedeva indagati numerosi militari per il reato di diffamazione militare aggravata (di cui agli artt. 47 n. 2 e 227 co. 1 e 2 c.p.m.p.).
Nello specifico i militari, proprio su una chat whatsapp di gruppo ristretta, inviavano foto di una collega accostandola a foto di altre donne in abbigliamento succinto e accompagnandole a frasi colorite e “goliardiche”.
La difesa, mediante le argomentazioni suesposte e la giurisprudenza citata, ha potuto ottenere sentenza di non doversi procedere: in alcun modo poteva parlarsi, nel caso di specie, di diffamazione militare aggravata, non essendo la chat whatsapp di gruppo valida a ritenersi un’aggravante del reato in questione, e la mancanza della condizione di procedibilità di cui all’art 260 c.p.m.p., non ha potuto che condurre alla sentenza di non doversi procedere.
Ebbene, lo stare al passo con i tempi, ha comportato l’inevitabile adeguarsi della giurisprudenza con il mutato contesto sociale. La capacità lesiva del mondo virtuale non lascia spazio alle leggerezze, ma la giurisprudenza è ormai chiara in ordine alle chat whatsapp di gruppo, le quali non sono configurabili nell’aggravante dell’uso del “mezzo di pubblicità”.
____________________________________________________
Avv. Michela Scafetta, penalista del foro di Roma
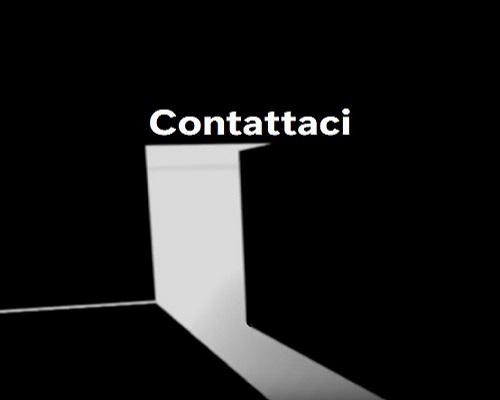
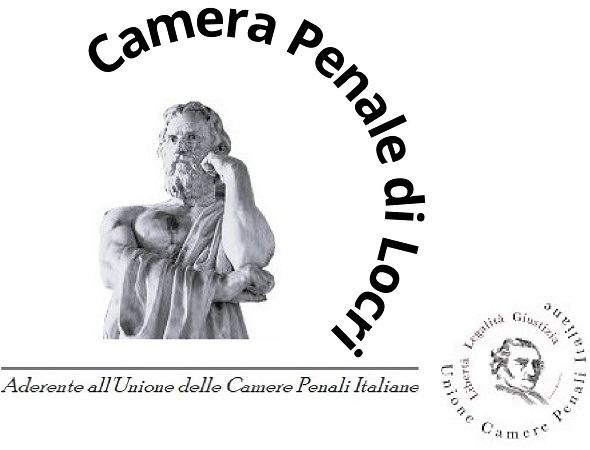
Utilizzando il Form acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni sulla nostra modalità di gestione della privacy, clicca qui
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni, clicca qui
