Il delitto di Insubordinazione, previsto e punito dal codice penale militare di pace, rappresenta, accanto al delitto di Disobbedienza, la fattispecie delittuosa più emblematica del diritto penale militare sostanziale, in quanto evocatrice, sin dallo stesso titolo, dei cardini dell’Ordinamento Militare, ovvero la gerarchia, il rapporto di subordinazione e il dovere dell’obbedienza, tanto da poter esser considerato, forse, il reato che più di ogni altro incarna la peculiarità del mondo militare, fatto di regole e di obbedienza.
Tale figura di reato è disciplinata dal Titolo III del codice, ovvero quello dei Reati contro la disciplina militare.
Il codice penale militare di pace prevede due tipi di Insubordinazione, quella con violenza, disciplinata dall’art. 186 e quella con minaccia o ingiuria di cui all’art. 189.
Il delitto si consuma attraverso una condotta violenta o minacciosa (o ingiuriosa) posta in essere da un militare contro un superiore in grado.
L’interesse tutelato dalla norma è quello della disciplina militare (intesa come l’osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare) e del rapporto gerarchico (sia funzionale che di grado) ad essa strettamente attinente, posto che l’esercizio della potestà disciplinare è collegato alla posizione gerarchica dei militari per cui al superiore spetta il controllo sull’osservanza dei doveri dei subordinati.
In verità, sia in dottrina che in giurisprudenza, ci si è posto il problema di quale fosse l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, ovvero, se fosse sic et simpliciter, il rapporto gerarchico o, addirittura, la persona del superiore.
Tale incertezza ha generato un contrasto interpretativo intorno alla possibilità di considerare o meno il superiore come persona offesa dal reato (in quanto pur sempre destinatario fisico dell’azione violenta o minacciosa), circostanza non ammissibile laddove si fosse aderiti alla tesi restrittiva secondo cui l’interesse tutelato dalla norma è solo ed esclusivamente il rapporto gerarchico.
Alla fine ha prevalso la tesi della plurioffensività di tale reato che, si è sostenuto, offenderebbe sia il bene giuridico dell’Autorità Militare che il superiore gerarchico, (quest’ultimo non in valore assoluto, bensì solo in considerazione della funzione militare svolta all’interno della scala gerarchica).
Tesi, quest’ultima, coerente con la previsione normativa di cui all’art. 199 c.p.m.p. (introdotta dalla L. 689/1985) secondo cui il delitto non sussisterebbe quando la condotta del subordinato avviene per “cause estranee al sevizio o alla disciplina militare”, a riprova del fatto che il superiore è tutelato quando incarna funzionalmente l’Autorità Militare.
Le due fattispecie (quella ex art. 186 nonché quella ex art. 189 c.p.m.p.) prevedono la pena della reclusione militare uguale nel massimo (tre anni), divergendo solo nel minimo (un anno nel caso di violenza, sei mesi nel caso di minaccia o ingiuria).
Tale discussa figura di reato, è tra quelle che più ha necessitato (e che di fatto ha subito) nel corso degli anni un’evidente evoluzione, rispetto alla iniziale formulazione, dovuta a reiterati interventi giurisprudenziali (soprattutto da parte del Supremo Giudice delle Leggi), oltre che legislativi.
Istituita nel 1941, l’originaria impostazione del codice (verosimilmente ispirata al clima politico dell’epoca), appariva poco razionale, laddove si consideri che condotte sostanzialmente identiche venivano punite con pene quantitativamente diverse a seconda che il soggetto offeso dal reato fosse un ufficiale od un sottufficiale.
A quel tempo, infatti, prima che la Riforma delle Forze Armate del 1978 introducesse un alone di democraticità, il militare era visto più come un suddito destinatario di ordini emanati dai propri superiori, la cui posizione, come dimostra l’originaria previsione normativa della fattispecie de quo, era più tutelata rispetto a quella dell’inferiore.
Tanto per dirne una accadeva che, nel caso di Insubordinazione con minaccia o ingiuria, la norma incriminatrice prevedesse la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore era un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non era un ufficiale.
Senza contare che lo speculare delitto di abuso di autorità – in cui l’azione delittuosa è rivolta in senso discendente, cioè dal superiore all’inferiore – prevedeva una pena più bassa comportando di fatto una disomogeneità a seconda che ad essere destinatario dell’azione violenta o minacciosa fosse il superiore o l’inferiore.
Solo reiterati interventi della Corte Costituzionale hanno corretto il tiro eliminando alcune sperequazioni inappropriate.
Sentenze come la N. 26 del 1979 nonché la N. 103 del 1982, hanno di fatto ridisegnato tale fattispecie (sia quella di cui all’art. 186 che quella ex art. 189 c.p.m.p.) nella parte relativa alla pena inizialmente prevista.
Appariva davvero irrazionale l’originaria previsione normativa che equiparava, in termini di pena, l’omicidio volontario del superiore al tentato omicidio o all’omicidio preterintenzionale. Così come appariva, altresì, illogica, in termini sanzionatori, la diversità di pena basata a seconda che il soggetto passivo della condotta criminosa fosse o meno un ufficiale.
Entrambe le norme furono dichiarate, a breve distanza l’una dall’altra, costituzionalmente illegittime in ordine al trattamento sanzionatorio in esse previsto.
Le citate sentenza della Consulta incisero significativamente su tale fattispecie provocando, di fatto, un vuoto normativo nella parte sanzionatoria, obbligando, così, il legislatore ad intervenire per risolvere il contrasto che si era venuto a creare tra dottrina e giurisprudenza sulle possibili vie d’uscita (mutuare il trattamento sanzionatorio da fattispecie similari o fare ricorso al principio di legalità e certezza del diritto che imponeva al legislatore di provvedere normativamente).
Tale vuoto normativo fu sancito da una nota pronuncia della Suprema Corte di quegli anni.
Invero, chiamate a pronunciarsi, a breve distanza dall’emanazione delle citate pronunce costituzionali, in tema di sussistenza del reato di Insubordinazione, le Sezioni Unite della Suprema Corte precisarono che “Per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 26 del 1979 e 103 del 1982 le norme di cui agli artt. 186 e 189 del codice penale militare di pace sulla insubordinazione sono state eliminate dall’ordinamento, subentrando ad esse, gli artt. 337 e 341 del codice penale allorché soggetto passivo del reato sia un superiore con qualifica di pubblico ufficiale. Ciò fino all’entrata in vigore della legge 26 novembre 1985 n. 689 che ha riformulato le dette norme del codice penale militare di pace reintroducendole nell’ordinamento”[1], così chiarendo che nelle more dell’ultimo intervento della Consulta del 1982 e l’entrata in vigore della L. 689/1985, le due fattispecie erano state di fatto eliminate dall’ordinamento giuridico, salvo rivivere di lì a poco proprio grazie all’entrata in vigore della detta legge.
Si è arrivati così alla riforma del 1985, con la L. n. 689, che, mutuando i suggerimenti della Corte Costituzionale, ha ridisegnato il delitto di Insubordinazione, soprattutto (se non in via esclusiva), nella parte relativa alla pena da infliggere al reo.
Attualmente, dunque, il delitto di Insubordinazione, sia con violenza che con minaccia, prevede la pena della reclusione, nel massimo, di anni tre, differenziandosi nel minimo (un anno nel primo caso, sei mesi nel secondo).
Quanto all’ipotesi disciplinata dal secondo comma dell’art. 189 (Insubordinazione con ingiuria) la pena è più lieve, posto che la norma incriminatrice prevede, quale trattamento sanzionatorio, un massimo di due anni, nulla disponendo in ordine al minimo (rimesso dunque alle regole generali della pena detentiva).
Superate, in un certo qual modo le originarie sperequazioni ontologiche relative alla figura delittuosa di cui trattasi, i successivi interventi della Suprema Corte hanno avuto come obiettivo quello di chiarire la portata e i limiti della fattispecie punibile a titolo di Insubordinazione.
I temi più dibattuti sono stati, in primis, quello relativo alla nozione e al significato di servizio e disciplina militare, contesto nel quale la condotta delittuosa – per essere considerata reato – deve necessariamente consumarsi.
Dopo l’entrata in vigore della L. 689/1985, che ha riformulato la norma di cui all’art. 199 c.p.m.p. secondo cui la sussistenza del reato è esclusa quando la condotta delittuosa è stata commessa “per cause estranee al servizio e alla disciplina militare”, ci si è posti il problema della corretta interpretazione di tale locuzione e dell’esatta portata della stessa, onde ritenere la sussistenza o meno del delitto di Insubordinazione a seconda del contesto in cui la condotta incriminata si è verificata.
Mentre in un primo tempo, a tal fine, si è tenuto conto prevalentemente della condizione “di intraneità o estraneità dal servizio attivo” della persona minacciata o ingiuriata (col risultato di considerare reato la condotta minacciosa o ingiuriosa rivolta ad un superiore in servizio attivo) successivamente si è spostata l’attenzione sulla figura del soggetto attivo, assumendo maggiore rilevanza l’eventuale inesistenza di una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l’autore del fatto ed il servizio militare.
Illuminante, sul tema, un recente arresto giurisprudenziale nel quale il Supremo Collegio ha chiarito che “La minaccia o l’offesa all’onore di un superiore (art. 189 cod. pen. mil. pace), rivolta dal militare appartenente alle forze armate al di fuori dell’attività di servizio attivo e non obiettivamente correlata all’area degli interessi connessi alla tutela della disciplina, rientra nella clausola di esclusione del reato di insubordinazione, prevista dall’art. 199 cod. pen. mil. Pace” (“cause estranee al servizio e alla disciplina militare”)[2]. Tale decisione afferiva il caso di un caporale dell’Esercito italiano fuori servizio ed in abiti civili che, senza qualificarsi prima, aveva inveito all’indirizzo di appartenenti all’Arma dei Carabinieri che gli stavano contestando alcune violazioni al codice della strada, in cui la Corte ha ritenuto insussistente il reato militare.
La pronuncia testé riportata, ha fornito un’interpretazione della norma di cui all’art. 199 c.p.m.p. più evoluta ed in linea con i tempi bilanciando gli interessi in gioco, ovvero da una parte la tutela della disciplina militare e del rapporto gerarchico, dall’altra quella della sfera di azione del militare agente al di fuori del servizio.
Il passo in avanti è stato notevole laddove si consideri che pochi anni prima la Corte di Cassazione esprimeva principi diametralmente opposti ritenendo sussistente il reato anche in assenza di rapporti gerarchici diretti tra reo e persona offesa[3], mentre adesso, attraverso un’interpretazione meno formale del concetto di disciplina militare si impedisce che la stessa invada in ogni momento e senza limiti la vita del militare (soggetto attivo) sia in servizio che fuori servizio.
Altro tema dibattuto, sia in dottrina che in giurisprudenza, in ordine a tale figura di reato, è quello relativo alla tipicità della condotta integrante le due figure di Insubordinazione.
Ma mentre la fattispecie di cui all’art. 186 (con violenza), riguardo alla condotta di reato, ha generato pochi dubbi interpretativi, la fattispecie di cui all’art. 189 (con minaccia o ingiuria) ha, di contro, necessitato di maggiori chiarimenti comportando, di fatto, non pochi interventi della Suprema Corte finalizzati a chiarirne, l’esatta portata.
Uno dei più significativi, afferenti l’idoneità della condotta ad integrare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 189 c.p.m.p., è del 2020. In esso il Supremo Collegio ha affermato che “Nel reato militare di insubordinazione con ingiuria, integra l’offesa all’onore ed al prestigio ogni atto o parola di disprezzo verso il superiore nonché l’uso di tono arrogante, perché contrari alle esigenze della disciplina militare per la quale il soggetto di grado più elevato deve essere tutelato, non solo nell’espressione della sua personalità umana, ma anche nell’ascendente morale di cui ha bisogno per un degno esercizio dell’autorità del grado e della funzione di comando”[4]. Il caso riguardava un militare che nel contestare un ordine del superiore, aveva profferito al suo indirizzo l’espressione: “non tieni le palle”, al di fuori di un contesto scherzoso e in violazione delle regole di disciplina militare.
Proprio tale pronuncia, una delle ultime riguardo il tema della condotta materiale del delitto di Insubordinazione, potrebbe dare adito a facili critiche nei confronti del sistema legislativo laddove si consideri che mentre da una parte, ormai da qualche anno[5], nel diritto penale ordinario, il legislatore ha proceduto alla depenalizzazione del delitto di ingiuria, nell’ambito militare fattispecie come quella di cui all’art. 189 c.p.m.p., – che ha come elemento essenziale proprio il delitto di l’ingiuria – non solo è rimasta tutt’ora vigente ma oltretutto per l’integrazione della stessa basta il semplice tono arrogante rivolto al superiore gerarchico.
Sebbene, dunque, istintivamente, possa apparire sproporzionato e anacronistico, ai giorni nostri, l’esistenza di una norma penale che preveda la privazione della libertà a causa di condotte che, in alcuni casi, si riducono a comportamenti sostanzialmente ineducati o inurbani, come la semplice parola di disprezzo o il tono arrogante rivolto al superiore, tuttavia occorre sempre considerare i principi che sorreggono il mondo militare (il rapporto gerarchico, il dovere dell’obbedienza), laddove, ancora oggi, la tutela della disciplina militare rappresenta un valore fondante e perciò meritevole di tutela.
Per comprendere, dunque, appieno la ratio di alcuni reati previsti dal codice penale militare, tra cui quello di Insubordinazione, occorre sempre fare riferimento ai valori che sorreggono la sfera militare che, al di là della naturale evoluzione da cui è stata interessata nel corso del tempo, conserva pur sempre, quali principi cardine necessari alla sua sopravvivenza, la disciplina, la gerarchia, e l’obbedienza, la violazione dei quali viene ancora oggi sanzionata.
Sono proprio tali aspetti che consentono di distinguere la giurisdizione militare da quella ordinaria, laddove si consideri che in quest’ultima, evoluzioni dottrinarie e/o giurisprudenziali hanno comportato, per stare al passo con i tempi, la depenalizzazione di condotte che, al contrario, a determinate condizioni, nel diritto militare sono ancora oggi punite.
_________________________________________________________
Avv. Domenico Albanese – penalista del Foro di Locri
NOTE:
[1] Cass. Sez. U, Sentenza n. 3 del 21/06/1986 Cc. (dep. 28/06/1986 ) Rv. 173260 – 01
[2] Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25353 del 15/01/2019 Ud. (dep. 07/06/2019 ) Rv. 276484 – 01
[3] Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19970 del 30/01/2013 Ud. (dep. 09/05/2013 ) Rv. 256179 – 01
[4] Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12313 del 19/02/2020 Ud. (dep. 16/04/2020) Rv. 278699 – 01
[5] D.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016
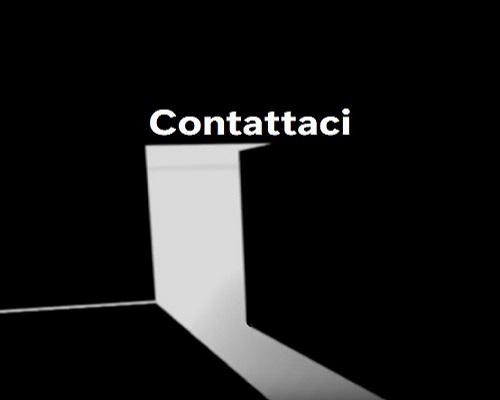
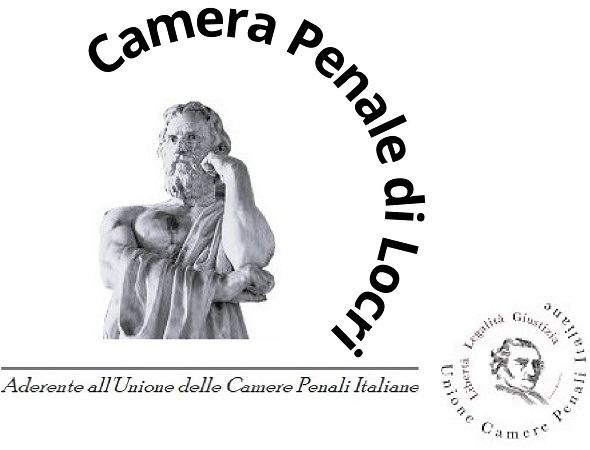
Utilizzando il Form acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni sulla nostra modalità di gestione della privacy, clicca qui
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni, clicca qui
