In tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto.
Nel ribadire il principio – da ultimo statuito da Quinta Sezione, n. 5896/2020, dep. 2021, CED 280453 -, la Corte ha escluso che, nel caso di specie, ricorresse un’ipotesi di falso innocuo, venendo in rilievo una dichiarazione di conformità ex art. 25, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, allegata dagli imputati ad una pratica di agibilità, redatta in maniera da occultare la reale destinazione d’uso di alcuni locali.
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Lecco, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per una serie di reati essendo estinti per intervenuta prescrizione, ordinava la demolizione delle opere abusive se non altrimenti eseguita (condannando i medesimi alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite) e confermava nel resto l’impugnata sentenza che, in accoglimento della tesi accusatoria, aveva ritenuto la penale responsabilità di tutti gli imputati in relazione al reato previsto dalla norma contenuta nell’art. 44 lett. b) T.U. edilizia “perché, nelle rispettive qualità, il (…) legale rappresentante della (…) committente dei lavori, il (…) legale rappresentante della (…) esecutrice dei lavori e, il (…), quale progettista e direttore dei lavori, realizzavano 9 villette in difformità totale della DIA alternativa al permesso di costruire. (Il progettista), inoltre, veniva condannato per il reato di cui all’art. 481, cod. pen., per aver attestato e certificato falsamente in relazione alle villette indicate la conformità ai progetti depositati, contrariamente al vero per le ragioni meglio descritte nel capo di imputazione”.
Gli imputati, proponevano ricorso per Cassazione, con una serie articolata di motivi.
La Suprema Corte reputava, solo in parte, fondati i gravami interposti rispettivamente “con riferimento all’intervenuta prescrizione dell’illecito edilizio di cui all‘art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 nonché del delitto di cui all‘art. 481, cod. pen., limitatamente alla contestazione relativa al fatto commesso in data 27.09.2013, con conseguente annullamento senza rinvio dei predetti reati per essere gli stessi estinti per prescrizione (…) e quanto al delitto di cui all‘art. 481, cod. pen., contestato (al solo progettista) come commesso in data 26.06.2015 (…) l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d‘appello di Milano”.
Partendo dal motivo accolto afferente l’intervenuta prescrizione del reato contestato, il Supremo Collegio ha evidenziato che i giudici di secondo grado hanno erroneamente reputato non prescritta la contestata contravvenzione edilizia (art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001) atteso che dall’istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che, nell’anno 2018, l’intervento edilizio non sarebbe stato ultimato.
La motivazione della Corte milanese si sarebbe ancorata alla deposizione di un teste che avrebbe affermato che, nell’anno 2018, il cantiere era ancora aperto e avrebbe “pertanto, (ritenuto) di versare nell’ipotesi di reato progressivo nell’evento poiché l’intervento edilizio deve essere valutato nel suo complesso, in quanto realizzazione di un piano di lottizzazione il cui progetto è stato presentato globalmente al Comune”.
La conclusione giudiziale, secondo la Suprema Corte, è erronea atteso che i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto conto della “struttura della contestazione mossa al capo 1), in cui il PM ha individuato la data del fatto “dal 26.06.2015 fino al 1.02.2016″”.
Ciò posto, sottolinea la Corte che, il reato edilizio contestato è un reato permanente e che “la permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l’accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, Rv. 260498 – 01)”.
Orbene, nel caso di specie, la permanenza sarebbe cessata con l’intervenuto sequestro avvenuto nel febbraio dell’anno 2016.
Di conseguenza, l’esistenza di un termine di cessazione del reato permanente e la sua precisa indicazione temporale all’interno del relativo capo di imputazione (1.02.2016) avrebbero dovuto condurre i giudici di secondo grado a considerare la contestazione “chiusa” non permettendo ai medesimi di “postergare il termine finale di consumazione dell’illecito edilizio”.
In tal senso, devesi rilevare quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “nel caso in cui l’imputazione relativa ad un reato permanente indichi il “tempus commissi delicti” con “formula chiusa”, e cioé con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell’imputazione e non dalla data di emissione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento (Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Rv. 274298 – 01)”.
Parimenti fondato è il motivo proposto dal “progettista” il quale lamentava violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto contestatogli e previsto dalla norma contenuta nell’art. 481 c.p..
Secondo il giudice di primo grado e la Corte d’appello territoriale, si sarebbe perfezionato il reato di “falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità” alla luce della “accertata sussistenza delle descritte difformità tra quanto contenuto nei progetti edilizi del complesso immobiliare e quanto effettivamente realizzato nell’ambito del complesso stesso”.
Nello specifico, il giudice di primo grado aveva evidenziato come, nella fattispecie in esame, “non si verte in tema di omessa produzione documentale degli allegati obbligatori ma di mancata corrispondenza al vero dell‘asserzione relativa alla conformità delle opere realizzate ai progetti edilizi in precedenza depositati, anche alla luce di tutte le modifiche intervenute nel tempo” e che “tale asserzione (…) non solo è pacificamente falsa, ma proviene altresì da un incaricato di servizio di pubblica necessità, posto che tale dichiarazione non può essere resa da chiunque, ma provenire da un tecnico o da colui che, in quanto tecnico, abbia in precedenza rivestito anche la qualifica di progettista”.
La Corte d’appello, ponendo la propria attenzione sulla certificazione depositata in data 26.6.2015, sosteneva che l’imputato, in qualità di tecnico collaudatore, avrebbe certificato la conformità delle opere agli atti progettuali depositati.
Orbene, la Corte milanese rilevava:
- che la certificazione di collaudo è normativamente prevista e, nello specifico, dalla norma contenuta nell’art. 20 DPR 380/2001 secondo la quale “ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività”;
- che l’obbligo indicato al punto che precede viene ribadito dall’art. 42 della L.R. Lombardia secondo cui “Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico per l’edilizia, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività”; che l’art. 13 del PL 25 stabilisce che “il collaudo dovrà eseguirsi … a seguito della presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei lavori attestante: la regolarità delle … costruzioni alle previsioni del Piano di Lottizzazione, nonché la conformità delle opere ai relativi permessi a costruire”;
- che, nel caso di specie, il progettista (odierno imputato), in caso di SCICA, avrebbe rivestito “la qualifica di esercente di pubblica necessita (cfr. art. 20 DPR 380/2001) ai sensi degli artt. 359, 481 cod. pen.”;
- che “non essendo previsti controlli preventivi e conseguenti permessi del comune a garanzia della regolarità delle opere, (seguendo la ratio della disciplina normativa) viene individuato un soggetto che di fatto si sostituisca ai funzionari, adempiendo al pubblico servizio di garantire il rispetto della normativa urbanistica”;
- che, di conseguenza, l’attestazione di conformità non è una valutazione, ma una certificazione attestante la conformità delle opere con i progetti depositati;
- che, infine, nel caso di specie, sussisterebbe la contestata contravvenzione edilizia (totale difformità rilevata in occasione dei sopralluoghi da parte dei tecnici comunali, successivi al deposito dei certificati di collaudo) atteso che “al posto di villette ad un solo piano fuori terra sono state rilevate palazzine di tre piani, tutti destinati a permanenza di persone”.
Orbene, secondo la Suprema Corte, l’impianto motivazionale non supera adeguatamente le censure mosse dalla difesa, le quali venivano reiterate dinanzi al giudice di legittimità.
Difatti, il ricorrente si doleva del fatto che la Corte di appello di Milano non avesse motivato in ordine alle censure contenute nell’atto di appello in relazione al reato ex art. 481 c.p. “limitandosi a richiamare solo l’esistenza della totale difformità in occasione del sopralluogo dei tecnici comunali (…) richiama(ndo) il resoconto delle pratiche di agibilità”.
Pertanto, secondo la difesa, “l’incertezza sulla configurazione del reato era individuabile sin dagli esordi della contestazione, in cui il capo di imputazione circoscrive il falso ad un certificato e ad una dichiarazione, termini tra loro non equipollenti”.
Senza dimenticare che “sarebbero dirimenti ad escludere la sussistenza del dedotto falso alcune circostanze”, di seguito, indicate: “inutilità del falso; falsità legata al giudizio di conformità su un dato vero; falsità consistita in un giudizio di conformità tra realizzato e pratiche edilizie; falsità punita confondendo l’art. 481, cod. pen. con le speciali norme sulle asseverazioni; falsità relativa non alle pratiche edilizie ma all’agibilità; falsità non assistita dalla prova del dolo; falsità si porrebbe in relazione alla possibile futura utilizzazione dei vani accessori, successivamente all’acquisto ed utilizzazione dei proprietari, come vani totalmente abitati; andrebbe tenuta in considerazione, infine, la sopravvenuta introduzione di norme più favorevoli che avrebbero depenalizzato il fatto”.
Ciò posto, secondo il Supremo Collegio, devesi preliminarmente focalizzare l’attenzione sul tipo di dichiarazione di conformità.
Trattasi, nel caso di specie, della dichiarazione di conformità prevista dalla norma contenuta nell’art. 25, lett. b), TUE, “diretta al comune di Lecco, redatta in data 26.06.2015 ed allegata alla pratica per l’agibilità (di un edificio), che sottoscriveva la richiesta insieme a (uno dei coimputati ossia al legale rappresentante di una delle ditte)”.
Orbene, la Suprema Corte ribadisce che “per pacifica giurisprudenza, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui, come quello in esame, l’infedele attestazione (nel falso ideologico) sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell’atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (tra le tante: Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280453 – 01)”.
Nel caso di specie, la dichiarazione di conformita ex art. 25, lett. b), TUE, “era diretta al comune di Lecco ed era allegata alla pratica per l’agibilità: deve quindi essere esclusa la ricorrenza del “falso innocuo” ”.
E, ancora, secondo il Supremo Collegio, non è possibile discutere, nella fattispecie in esame, “di mancanza di segnalazione certificata, ma, nella prospettiva accusatoria, di infedele attestazione in ordine alla sussistenza delle predette condizioni ed alla conformità dell’opera al progetto presentato e alla sua agibilità, donde non vi è dubbio in ordine alla persistente rilevanza penale di tali dichiarazioni”.
Invece, sarebbero rimasti senza risposta i seguenti profili rimarcati dalla difesa e di assoluto rilievo:
- “il tema della falsità dell’atto che sarebbe stata legata, nella prospettazione difensiva, al giudizio di conformità su un dato vero (rilevandosi che le schede catastali erano state ritenute rispondenti alle pratiche edilizie, donde il contenuto della dichiarazione attinente la rispondenza conforme dei lavori ai titoli edilizi, ovvero alle modifiche della DIA in variante e SCIA del 2015 non sarebbe per la difesa penalmente rilevante)”;
- “(il tema afferente la contestazione di un) falso (che) sarebbe consistito in un giudizio di conformità tra realizzato e pratiche edilizie, che non rileverebbe penalmente secondo la giurisprudenza richiamata”;
- “l’esistenza di una possibile confusione tra l’art. 481 cod. pen. e le disposizioni riguardanti le norme sulle asseverazioni di cui all’art. 20, comma 13, e 23 TUE (ciò, aggiunge il Collegio, soprattutto alla luce della giurisprudenza la quale ritiene che il reato di cui all’art. 20, comma 13, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che punisce le false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni circa l’esistenza dei requisiti e presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ha un ambito applicativo che si sovrappone interamente alla fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessita (art. 481 cod. pen.) e di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui assorbe il disvalore, e si consuma quando oggetto di asseverazione non siano esclusivamente fatti che cadono sotto la percezione materiale dell’autore della dichiarazione, ma giudizi (Sez. 3, n. 29251 del 05/05/2017, Rv. 270432 – 01)”;
- “(il fatto che) il giudice di appello non ha fornito risposta alla censura difensiva che contestava l’assenza di prova dell’elemento psicologico del reato, atteso che la dichiarazione di cui si discute era stata redatta sulla base di un dato di fatto rappresentato fotograficamente, donde non sarebbe stato possibile intervenire con contrarie false attestazioni”;
- “la considerazione per la quale il falso si sarebbe posto in relazione alla futura utilizzazione dei vani accessori, successivamente all’acquisto ed utilizzazione dei proprietari, come vani totalmente abitati, donde la contestazione mossa al (progettista) non sarebbe stata al medesimo ascrivibile, non spettando al medesimo valutare potenziali usi futuri dei locali quali i vani accessori dei locali sottotetto ed interrato (e, sul punto, non può non rilevarsi che la responsabilità penale quale persona esercente un servizio di pubblica necessità per il reato di falsità ideologica in certificati che renda false attestazioni, è subordinata alla condizione che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest’ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato: tra le tante: Sez. 3, n. 27699 del 20/05/2010, Rv. 247927 – 01)”.
Orbene, secondo la Suprema Corte, “è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate
critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello (tra le tante: Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Rv. 271700 – 01)”.
La mancata risposta giudiziale in ordine ai punti precedentemente indicati ha imposto l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano con riferimento al vuoto argomentativo da colmare in relazione delitto contestato al ricorrente e previsto dalla norma contenuta nell’art. 481, c.p..
Cass. Pen., Sez. III, Ud. 10 novembre 2023, n. 47909
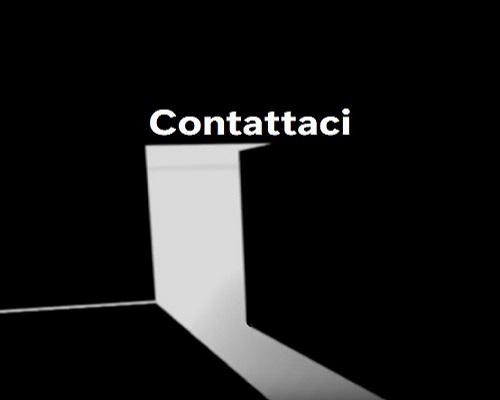
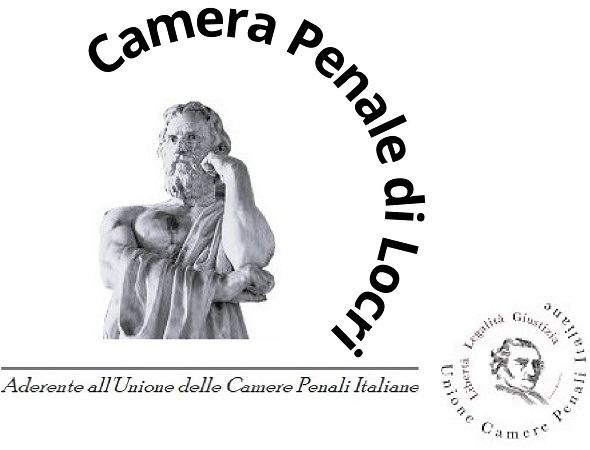
Utilizzando il Form acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni sulla nostra modalità di gestione della privacy, clicca qui
Iscrivendoti alla nostra Newsletter acconsenti al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni, clicca qui

